Capitolo VIII — La sera ad Altares
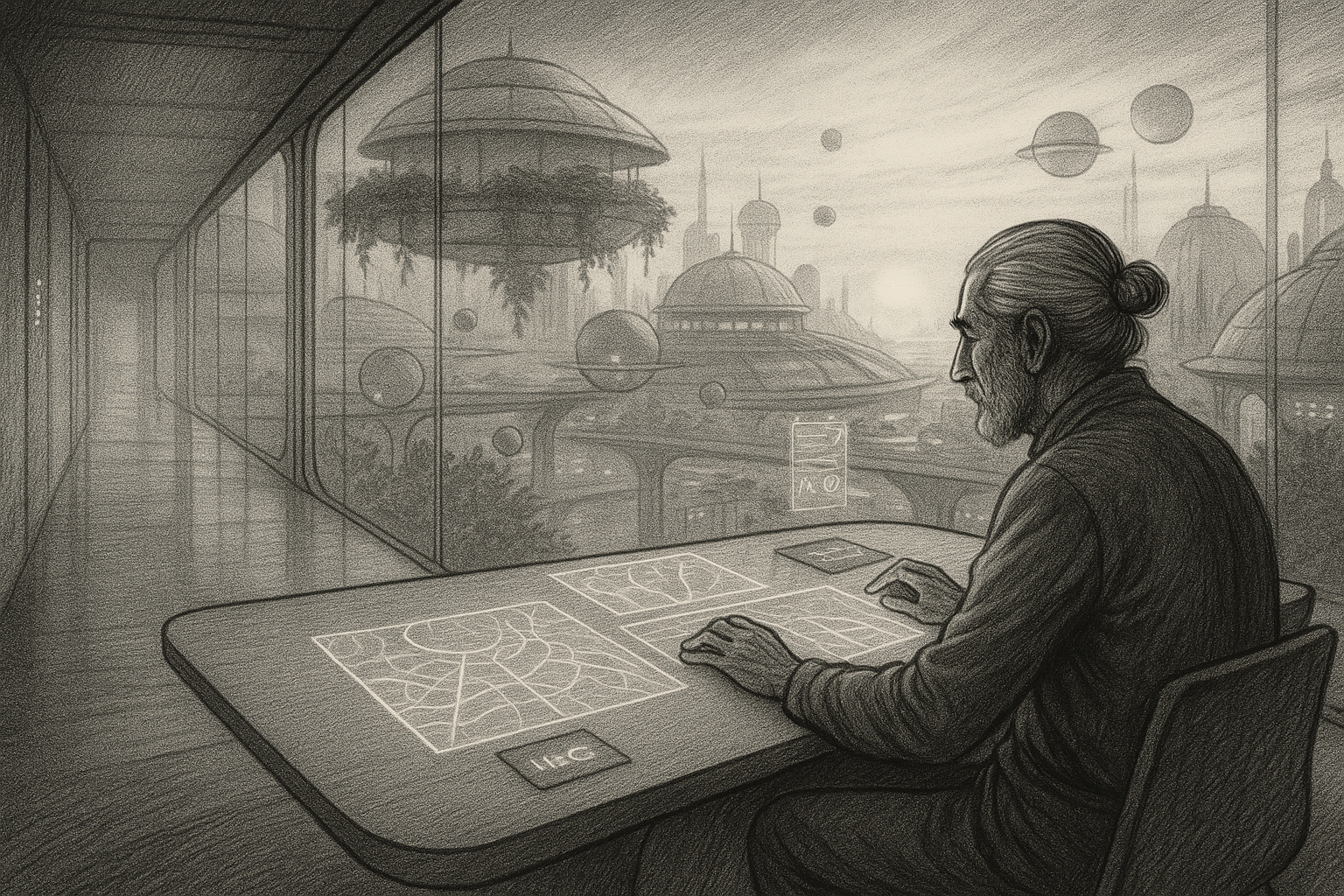
Il tramonto di Altares non scendeva: veniva appunto calibrato. Le pareti della casa si accordarono a una tonalità rame, simulando il riflesso di un sole che nessuno vedeva direttamente. L’aria si fece più densa, tiepida, profumata di resina: una nostalgia nanometrica, programmata per far credere al corpo che il giorno si fosse davvero consumato. Sul tavolo senza bordo, le mappe dormivano nel loro reticolo di luce, eppure lui ci tornava sopra con le dita, come chi ripassa un ricamo che conosce a memoria per il solo bisogno di toccarlo.
Il padre restò a lungo immobile, con i gomiti sospesi a mezz’aria, come se l’idea stessa di poggiarsi gli sembrasse un’infrazione. Aveva spento la colonna di richiami del lavoro tre volte, e tre volte l’aveva riaccesa: particelle, dati, linee di rotta, coordinate che non descrivevano un luogo ma un’assenza. Si scoprì a sorridere della propria ostinazione; poi il sorriso gli cadde dalle labbra, come un oggetto che si accorge di non avere un posto su quel tavolo liscio.
— Randy, stato esterno — disse piano.
La voce di Randy apparve senza luogo, con la neutralità rispettosa dei servitori perfetti.
— Attività atmosferiche stabili. Cappa magnetica regolare. Flussi di trasporto a tracciamento ottimale.
— Persone?
Una sottilissima pausa, come un respiro trattenuto.
— Densità di passaggio nella vostra sezione: ventitré unità al minuto. Il gruppo di riferimento di Elara si è disperso in tre nuclei; rilevo scambio ludico-lumetrico e vocalità elevata nella piazza sopraelevata C-Delta.
La parola “ludico” lo punse con una pena sciocca. Veniva ancora da una generazione che distingueva tra gioco e tempo perso. Avrebbe voluto non esserlo, ma lo era. Prese il bordo invisibile del tavolo con due dita; sentì l’elasticità della materia che, docile, concedeva un leggero cedimento.
Elara. In quel nome gli salivano addosso interi corridoi di giorni: la bambina che apriva i moduli della casa per vedere “come respiravano”, la ragazzina che correva sui giardini sospesi e si voltava indietro solo per ridere più forte, la giovane donna che gli parlava contro con la ferocia tenera di chi vuole salvarti dalla tua stessa serietà. Avrebbe voluto dirle che la capiva e che, proprio per questo, temeva. Ma ogni volta che provava a posare sul tavolo una frase finita, gli si scomponeva tra le dita in numeri, diagrammi, indizi: era il linguaggio che conosceva. E la lingua che si eredita non si cambia come una tazza.
Sfiorò un fascio di simboli: frammenti catalogati, annotazioni, tracce provenienti dagli Archivi esterni. Tutto parlava di prima. Non prima di lui: prima dell’ordine attuale, prima dei dodici domini in equilibrio instabile, prima che l’umano si confondesse con l’infrastruttura. C’erano nomi cancellati, coordinate smozzicate, leggende. In qualcuno di quei frammenti, a sprazzi, si udiva la parola Terra come un colpo di tosse in una stanza dove nessuno tossisce più.
Elara aveva detto: “La memoria può aspettare.” Era un errore grammaticale del mondo, non una disobbedienza personale. La memoria non aspetta: si assottiglia. Scivola via senza fare rumore, come fanno i gas nelle camere a pressione: quando te ne accorgi è già bassa, e non basta più a respirare.
— Randy, proiezione di luce 20%, riscaldamento al minimo — disse. Voleva che la casa rallentasse. Che tutto si disponesse a una semplicità antica.
— Confermato.
La stanza obbedì. La luce diventò quasi un braciere, il pavimento perse un grado di morbidezza: come camminare su legno. Fu un piccolo inganno, ma gli fece bene. Gli parve di sentire il tempo, per un attimo, scendere al suo passo.
Guardò la sedia opposta. Non c’era impressione di peso su quel posto: l’unità registrava tutto, dagli appoggi ai residui di temperatura corporea, e in quell’assenza lui avvertì l’esatta misura della sua attesa. Avrebbe voluto cominciare la sera dicendo “oggi ho trovato qualcosa”, non per vincere, ma per invitarla. Avrebbe voluto consegnarle una narrazione abbastanza potente da competere con i divertimenti sospesi. Gli mancava un aggancio. Gli mancava, da tempo, la brezza che solo l’entusiasmo dei giovani sa aprire nelle stanze.
Pensò alla madre di Elara. Il pensiero arrivò con l’austerità di una visita in ritardo. Non si soffermò sul dolore; si soffermò sulle conseguenze della sua assenza: la loro casa era diventata un dialogo a due voci, nessuna delle quali sapeva fare da terza. Quella terza voce avrebbe smussato, cucito, spinto via il troppo, tenuto fermo l’essenziale. Ora, quando lui e Elara si parlavano, avevano l’impressione di lanciare corde da una riva all’altra: e non sempre le corde trovavano appiglio.
— Randy — disse, più piano — quando torna, non annunciare. Lasciala entrare com’è.
— Ricevuto.
Chiuse gli occhi. Li riaprì quando una proiezione periferica gli segnalò un fascio di dati in arrivo dagli Archivi secondari. Un “frammento” — che parola impropria — non era che un residuo dotato di forma, spesso inutile, talvolta apocrifo. E tuttavia, nel posarlo dentro il catalogo, qualcosa in lui si raddrizzava; come se quel gesto non appartenesse solo a un mestiere, ma al gesto minimo che tiene insieme il mondo. Lo scaricò con la cura con cui si poggia un neonato in una culla. Poi si fermò, guardò la porta.
Gli sembrò di sentire un eco remoto, la vibrazione di una piattaforma che rientra a livello. Non chiese conferme. Semplicemente seppe che era lei.
La porta non si aprì: svanì. Le pareti risucchiarono un segmento a forma di ingresso e lo restituirono un istante dopo con Elara dentro. Aveva la pelle lievemente arrossata — effetto degli strati di luce sulle piazze elevate — e negli occhi quel riflesso lucido che le veniva dalle risate lungo la città. Si fermò sulla soglia come fanno gli atleti prima di entrare in acqua, e l’acqua in questo caso era il padre seduto alla sua sedia.
— Ciao — disse, semplice. Non fece la furba, non allungò una battuta per coprire il vuoto. L’intelligenza dei suoi anni le suggerì che la brevità è, a volte, una carezza.
— Ciao — rispose lui, e nella parola c’era l’inventario intero dell’attesa.
Randy ebbe la discrezione programmata di tacere. Nessun ben tornata, nessuna sintesi dello stato domestico. Su quell’assenza di annuncio si stese un silenzio vivo, non ostile: una temperatura d’ascolto.
Elara posò il palmo sul tavolo. La superficie si adattò alla sua linea vitale. Per un istante comparvero numeri: pulsazioni, microstanchezza muscolare, un’ansa di disidratazione connessa al flusso alto di parole che aveva attraversato nelle ore precedenti. Lei alzò un sopracciglio, come a dire: non origliare. Il tavolo, buon servo, fece scivolare via i dati in un gesto che somigliava a un arrossire.
— Ti ho preso una cosa — disse, tirando fuori dalla tasca un ninnolo di luce. Non esistevano davvero “cose” nei loro spazi; esistevano protocolli d’uso travestiti da oggetti. Quello pareva un vecchio fermacarte, ma conteneva dentro un filtro: se lo posavi su una mappa la semplificava, la rendeva leggibile anche a chi non aveva dimestichezza con i livelli.
Il padre allungò la mano, lo toccò, lo lasciò andare subito. Non voleva interpretare il dono come una trattativa: io ti porto un gioco, tu mi lasci in pace con i frammenti.
— Grazie — disse soltanto. — Ti è piaciuta la città?
— È sempre uguale e sempre diversa — rispose Elara. Si sfilò le scarpe, oggetti di scena, più che calzature, comodità simulate, e lasciò che il pavimento le risalisse un poco sotto i piedi, come sabbia tiepida. — Joran ha fatto piovere sul vuoto, Mira ha discusso con un uccello-drone. Io ho camminato sull’acqua solida e ho pensato che è buffo: camminiamo su distanze che non sappiamo nominare.
Sorrise. Poi smise di sorridere, perché vide, non un rimprovero, ma un’ombra nell’azzurro degli occhi del padre. Portava la stanchezza di chi usa due lingue tutto il giorno: il lessico dei codici e quello dell’amore.
— Non sono venuta — disse lei, senza girarci attorno. — all’Archivio.
La casa rimase ferma. Un buon luogo non ingigantisce le frasi.
— Lo so — rispose lui. — Non ti sto aspettando per farmelo dire.
Si guardarono come si guardano due piani della stessa casa: uno abitato di giorno, l’altro di notte. Nessuno dei due più importante. Solo diversi.
— Ho pensato a te — aggiunse Elara, quasi con stizza verso se stessa. — Tra le piazze. Non per senso di colpa. Perché… mi mancava la tua mania. Quella che mi fa arrabbiare. Quella che mi tiene.
Il padre non si mosse. Nelle sue pupille passò una minuscola tregua.
— La mania è un nome che diamo alle cose quando ci spaventano — disse il padre. — Se dico “metodo” la parole rimane asciutta; se dico “mania”, posso scaldarmi l’ironia tra le mani. Ma sì, lo ammetto: anch’io la chiamo mania, a volte, quando non mi ascolto più.
Elara girò attorno al tavolo lentamente, come se misurasse la stanza con i passi. Ogni gesto di lei era un’indagine. Ogni ruga di lui, una mappa.
— Raccontami comunque — disse. — Come se fossi venuta. Fingi che io sia stata una figlia migliore.
— Non esistono figlie migliori — rispose lui. — Esistono giorni peggiori.
Il modo in cui lo disse non era un perdono; era un modo per sedersi accanto senza spostare le sedie.
Lui fece comparire un pannello minimo, niente più grande di un palmo. Non si aprì l’oceano delle mappe, solo una stilla. Elara avvertì la grazia del gesto: l’uomo che sa rinunciare alla sua ampiezza per non sommergerti. Sul palmo tremò un grano di immagine: non un segno riconoscibile, neppure una parola. Una grana. Come la trama di un tessuto antichissimo.
— È un frammento materiale scansionato, non un ologramma originario — disse lui. — Conserva una pelle. Ho imparato che è lì che i mondi si tradiscono: sulla pelle.
Elara si chinò, vicinissima. Inspirò senza far rumore, come fanno gli artigiani quando stanno per usare l’utensile giusto.
— Sembra… caldo — disse. Non era un’impressione tattile, era una metafora che le saliva dalle immagini dei suoi sogni. — E ha una riga che non c’entra con la trama.
— Una correzione — annuì il padre. — Qualcuno, molto tempo fa, ha tracciato una linea per ricordare a se stesso dove finiva il possibile.
La casa reclinò un’ombra verso il rosso. Il finto tramonto avanzava. Randy, in un angolo dell’aria, sollevò appena il profilo dei parametri: idratazione, zuccheri, luce. Il padre ignorò. Elara tese un dito.
— Posso?
— Tocca pure.
Lei sfiorò la porzione di pelle antica. La proiezione reagì come reagiscono le membrane quando riconoscono una vibrazione compatibile: con un tremito minimo. Elara richiuse la mano.
— Capisco perché ti piace — disse, e la voce le uscì quasi tenera. — Ha difetti. E i difetti hanno memoria.
Il padre abbassò il pannello. Non spense. Solo abbassò, come si fa con una candela quando si desidera ancora luce, ma non abbaglio.
Il padre rimase al tavolo, Elara invece si era fermata a metà della stanza, incerta se andare a dormire o restare. Il buio modulato dalla casa non era mai buio vero: linee soffuse correvano lungo gli angoli, una luminescenza tenue che faceva sembrare ogni stanza la replica di un crepuscolo senza fine.
— Papà? — disse lei, tornando indietro piano. — Possiamo parlare ancora un po’?
Lui sollevò lo sguardo dal frammento che aveva davanti. Non era sorpreso: Elara non chiudeva mai davvero le conversazioni, le lasciava sospese come corde tese nell’aria.
— Certo. La notte non ha mai fretta.
Lei si accoccolò sulla sedia di fronte, incrociando le gambe, e si versò un bicchiere d’acqua. Ne bevve un sorso, poi tamburellò con le dita sul bordo.
— Tu credi che io abbia paura della memoria, vero? — iniziò, sfidandolo. — Che io scappi da quello che studi perché non reggo il peso.
— Non lo credo — rispose lui. — Ma so che non la prendi sul serio. La tratti come un oggetto noioso.
Elara rise, ma era una risata spezzata.
— Forse è vero. Ma io non voglio passare la mia vita a rincorrere morti e segni cancellati. Voglio vivere ora. Voglio ridere, correre, sbagliare. Non vedi che là fuori c’è già tutto? Giardini che respirano, città che non dormono…
— Giardini che respirano — ripeté il padre, con un tono che non era scherno, ma eco. — E tu non ti chiedi mai chi li ha fatti respirare? O cosa c’era prima che respirassero?
Lei scosse la testa, agitata.
— Non mi importa. Non voglio passare la vita a chiedermi cosa c’era prima. Io sono qui, ora.
— È così che si muore in silenzio — ribatté lui, più duro del solito. — Non con il corpo, ma con la mente. Un mondo che non sa da dove viene è un mondo che non saprà mai dove andare.
Il silenzio si allungò. Randy emise un leggero impulso, come per offrire una tregua, ma il padre lo zittì con un gesto.
— Vedi — disse poi, più piano — tu sogni campi e legna, odori che non hai mai respirato. Non sono illusioni. Sono tracce. La memoria ti parla, anche se tu la rifiuti.
Elara lo fissò, trattenendo il respiro.
— E se fossero solo invenzioni della mia testa? Se fossero… desideri?
— I desideri non inventano così bene — rispose. — Sono le memorie a travestirsi da desiderio.
Lei chinò il capo, e per un attimo parve fragile. Poi rialzò lo sguardo, fiero.
— E se fosse il contrario? Se la memoria non fosse che il desiderio degli altri di piegarmi al loro passato? Le Corporazioni non fanno forse così? Ci raccontano storie, ci danno miti, ci impongono simboli… È memoria anche quella? O è solo una catena?
Il padre rimase in silenzio. Quella era una ferita vera. Le dodici Corporazioni si nutrivano di memorie costruite: dogmi religiosi, glorie di guerre, favole commerciali. Ognuna rivendicava un’origine, ognuna pretendeva di custodire la verità.
— Hai ragione — ammise infine. — Molta memoria è inganno. Ma il fatto che ci siano ombre false non significa che non esistano ombre vere.
— E tu credi di saperle distinguere? — incalzò lei. — Davvero pensi che i tuoi frammenti siano meno manipolati delle loro favole?
Lui non si offese. Anzi, parve quasi sollevato che lei fosse così tagliente.
— No. Non le so distinguere del tutto. Ma continuo a cercare. Perché se smetto, allora le Corporazioni hanno vinto. E io non lascerò che vincano anche dentro di noi.
Elara si passò una mano nei capelli. Il suo respiro era veloce.
— Io non voglio vivere come se fossi in guerra con qualcosa che non vedo. Io voglio vivere con quello che ho. Tu non capisci… a volte ho paura che, a forza di inseguire i tuoi fantasmi, tu ti dimentichi di me.
Le parole uscirono come un colpo, e quando caddero sul tavolo, rimasero lì, pesanti.
Il padre abbassò lo sguardo. Restò a lungo in silenzio, poi parlò con voce bassa, incrinata.
— Non mi dimentico di te, Elara. Ma è vero: a volte ti metto accanto ai miei frammenti. Non perché tu valga meno, ma perché penso che tu sia la sola che possa capirli davvero.
Elara deglutì. Non si era aspettata quella confessione. Non era un rimprovero, non era un’accusa. Era una nudità.
— Io non so chi sarò — disse lei, quasi in un sussurro. — Non so se voglio appartenere a una Corporazione, non so se voglio studiare con te, non so se voglio restare qui. Io… non so niente.
— Allora sei pronta — rispose lui. — Solo chi ammette di non sapere niente è pronto a conoscere.
— E tu cosa sei, papà? — lo incalzò lei, con un filo di ironia per coprire l’emozione. — Sei pronto o sei già troppo pieno di sapere per imparare ancora?
Lui rise, una risata amara ma sincera.
— Sono vecchio abbastanza da sapere che la mia sete non si placa mai. E che forse morirò assetato.
Elara allungò la mano e gli strinse le dita. Non c’era più sfida, non c’era più conflitto. Solo due esseri umani che cercavano di afferrarsi in mezzo a un mare che nessuno dei due comprendeva del tutto.
Il tempo scivolò lento. Randy segnalò che era passata un’ora, ma nessuno dei due si mosse. La casa modulò ancora la luce, portandola quasi al buio.
— Papà? — disse Elara, piano.
— Sì?
— Se un giorno i miei sogni si spegnessero, tu continueresti a crederci al posto mio?
— Sì — rispose lui senza esitazione. — E se un giorno le mie ricerche si spegnessero, tu continueresti a ridere al posto mio?
Lei rise, e le lacrime le tremarono negli occhi.
— Sì
Il padre prese fiato, come se le parole che stava per dire fossero più pesanti di quelle dette fino a quel momento.
— Tu pensi che io mi rifugi nei frammenti per paura del presente. Ma io non sono solo un uomo che colleziona ricordi: io lavoro per Mnemosyne.
Elara aggrottò la fronte.
— Lo so. E per questo a volte ho l’impressione che tu non sia libero. Mnemosyne ti ha dato un compito, e tu lo confondi con la tua vita.
— Non lo confondo, Elara. Io sono Mnemosyne. Come tutti quelli che hanno scelto una corporazione.
Lei rise piano, ma era una risata dura.
— Non tutti scelgono, papà. Molti nascono già dentro una corporazione e non hanno alternativa. Non fingere che sia libertà.
Il padre la guardò, serio.
— Non è libertà. È necessità. Le corporazioni ci tengono uniti. Senza di loro non ci sarebbe assemblea, non ci sarebbe legge, non ci sarebbe alcun ordine.
— C’è ordine? — lo incalzò lei, con gli occhi che brillavano di ironia. — O c’è solo una guerra silenziosa in cui tutti fingono di sorridere?
Per la prima volta lui non rispose subito. Le dita si mossero sopra il tavolo, ma non attivarono alcun pannello.
— Hai ragione. Ogni corporazione vuole più pianeti, più spazio, più potere. Siamo dodici arpie che si contendono lo stesso cadavere. Ma senza questo equilibrio instabile, la nostra specie sarebbe già collassata.
Elara lo fissò.
— E tu pensi che il tuo inseguire “frammenti” possa davvero cambiare qualcosa in questa lotta di potere?
— Non solo penso, lo so. Perché la memoria è potere. Senza memoria, le corporazioni non potrebbero giustificare nulla di ciò che fanno. Noi di Mnemosyne conserviamo l’unica moneta che tutti devono usare: il passato.
La voce di lui si fece più accesa. Elara lo guardava, e in quel fervore riconosceva non solo il padre, ma il rappresentante della corporazione. Un uomo che parlava come se portasse un sigillo.
— Capisci adesso? — continuò. — Ogni volta che recupero un frammento autentico, ogni volta che scopro un’indicazione che non è stata corrotta dalle leggende, io non salvo solo la memoria: metto in discussione il potere delle corporazioni. È per questo che non posso smettere.
Elara rimase in silenzio a lungo. Poi appoggiò la testa sulle mani, stanca.
— E io che c’entro, papà? Io che non voglio scegliere, che non voglio giurare a nessuna corporazione… Io dove mi colloco?
Il padre la guardò con un’intensità che la fece vacillare.
— Tu sei il mio futuro, Elara. Non quello di Mnemosyne. Il mio. Ed è questo che mi terrorizza: che la mia ossessione ti sottragga la possibilità di essere solo te stessa.
Lei deglutì. Non se l’aspettava. Non un uomo che parlava come emissario di Mnemosyne, ma come un padre che temeva di perdere sua figlia.
— Non voglio diventare un’ombra nei tuoi archivi — sussurrò.
— Non lo diventerai — rispose lui con fermezza. — Perché la tua voce è troppo viva. Mnemosyne non saprebbe contenerla.
Un silenzio li avvolse. Fu un silenzio denso, non vuoto: pieno di promesse e paure.
Elara si alzò infine, con un movimento lento.
— Papà… io non so se credo nella memoria come fai tu. Ma se davvero la memoria è potere, allora ti prego: non usarla solo per Mnemosyne. Usala anche per me. Per noi.
Lui si alzò a sua volta. Non la abbracciò, non era un gesto che gli veniva naturale. Ma posò la mano sulla sua spalla, e per Elara fu più di mille abbracci.
— Promesso — disse piano.
E quella promessa, per un attimo, parve più forte delle dodici corporazioni messe insieme.
Il silenzio calò come un animale che si accuccia nella stanza. Non c’era ostilità nel suo peso, ma un tepore inaspettato, quasi un invito a rimanere immobili. Le pareti obbedirono, smorzando la luce in un arancio fioco che si increspava come brace sotto la cenere.
Elara sedette di nuovo, il corpo piegato in avanti, il mento appoggiato alle ginocchia. La sua energia febbrile di poco prima era svanita: adesso sembrava piccola, raccolta, quasi stanca. Il padre la osservò senza muoversi, come si guarda una fiamma che trema ma non si spegne.
Randy, discreto custode, modulò i parametri interni: ridusse i flussi d’aria, ammorbidì il pavimento, eliminò ogni vibrazione inutile. Era come se la casa stessa avesse compreso che quel silenzio non doveva essere disturbato.
Il padre allungò la mano, non verso di lei ma verso il tavolo. Non evocò mappe né frammenti: solo un bicchiere. La materia prese forma lentamente, come se esitasse a incarnarsi, e lui glielo porse senza dire nulla. Elara lo prese con un cenno appena percettibile, bevve un sorso e posò di nuovo il bicchiere. Nessuna parola passò tra loro, ma quel gesto ebbe il peso di una frase lunga.
Sul bordo del tavolo brillava ancora un riflesso tenue, residuo del frammento che avevano osservato poco prima. Non era immagine, non era luce vera: solo un tremore, come il respiro di un ricordo che non vuole morire. Elara tese la mano e, senza toccarlo, lo sfiorò con l’ombra delle dita. Poi lasciò ricadere il braccio sulle ginocchia.
Il padre distolse lo sguardo, fissando il punto vuoto accanto alla porta. Non c’era nessuno, ma in quel vuoto parve avvertire un’eco. Non pronunciò il nome che gli saliva alla gola: sapeva che Elara avrebbe capito lo stesso. L’assenza si fece presente come un odore che non se ne va, sottile ma persistente.
Elara alzò lo sguardo verso di lui. Per un istante i loro occhi si incrociarono e tacquero entrambi, come se temessero di tradire un pensiero che li avrebbe feriti. Poi lei si chinò e raccolse dal tavolo i frammenti dispersi di dati che lui aveva lasciato aperti. Li ordinò con gesti rapidi, quasi con rabbia, ma la rabbia non era contro di lui: era un modo per addomesticare il caos che li circondava.
— Sempre disordinato — mormorò, ma senza durezza.
Lui sorrise appena, un sorriso fragile, che tremava più delle luci della stanza. Non rispose, ma accettò quell’appunto come si accetta una carezza nascosta sotto una critica.
Il silenzio rimase, eppure non era più lo stesso. Non aveva più il peso della frattura: era diventato un ponte. Ogni piccolo suono — il respiro di lei, il fruscio delle sue dita che scorrevano sul tavolo, lo scricchiolio quasi impercettibile della materia che si adattava al calore dei loro corpi — era un filo sottile che li teneva uniti.
Per qualche minuto non furono più padre e figlia, né ricercatore e giovane ribelle: furono solo due solitudini che si riconoscevano a vicenda.
La luce calò ancora, e il silenzio li avvolse come un mantello. La madre non c’era, eppure c’era: nella maniera in cui la stanza si piegava, nei vuoti che loro due non riuscivano a colmare. E proprio in quel vuoto si trovava la riconciliazione: non nel colmare la mancanza, ma nell’abitarla insieme.
Il padre si alzò infine, con un movimento lento. Non disse nulla. Versò da bere anche per sé, lo fece scivolare in gola, e si sedette di nuovo, questa volta più vicino a lei. Non abbastanza da toccarla, ma abbastanza da condividere lo stesso spazio d’ombra.
Elara posò la testa sul tavolo, chiudendo gli occhi. Non dormiva ancora, ma il suo respiro si era fatto più regolare. Il padre la guardò, e in quell’istante comprese che non avrebbe mai potuto chiedere di più.
Non la memoria, non i frammenti, non Mnemosyne: nulla valeva più di quel silenzio condiviso.
Rimasero così, uno di fronte all’altra. Poi lei riprese aria, con quella sua abitudine di dire tutto o niente.
— Posso dirti una cosa? Ma promettimi che non ti arrabbi
— No — rispose lui, e sorrise. — Ma puoi dirmela lo stesso.
— A volte ho paura che… che il tuo passato non sia il nostro futuro. Che se lo inseguo con te io diventi te. E io ti voglio bene, ma non voglio diventare te.
Non c’era veleno, lì dentro. C’era il punto esatto in cui i fili di una casa rischiano di farsi cappio. Il padre non si irrigidì. Prese tempo. Era l’unico lusso che sapeva regalare nei momenti in cui un’altra persona gli chiedeva verità.
— Non ti ho mai chiesto di diventare me — disse. — Ti chiedo di non diventare nessuno.
Lei strinse gli occhi.
— Nessuno?
— Sì. Quello che non lascia traccia. Quello che attraversa una stanza come fosse un algoritmo ben scritto: funziona, ma non resta.
Elara si morse l’interno della guancia. Si avvicinò, gli prese la mano. Le sue dita avevano la fiducia impudente dei giovani e il tremito di chi sa che sta toccando una frontiera.
— Non diventerò nessuno — disse piano. — Ma tu promettimi che, quando troverai ciò che cerchi, mi chiamerai prima di chiamare gli altri. Anche se io sono in città a ridere di niente.
— Lo prometto — disse lui, e non mentì.
La promessa si posò nella stanza come un oggetto reale, una cosa con peso. Randy la registrò senza etichetta, come si registrano le cose sacre: nei sistemi che non si loggano.
Stettero ancora un poco, senza parlarsi. Elara si mosse verso il nucleo cucina e fece comparire due bicchieri lunghi d’acqua fredda — acqua vera, non bevande adattive. Il padre la guardò: era una piccola insubordinazione al comfort. Bevvero. L’acqua scese con quell’antica brutalità che tutto spiega.
— Domani — disse lei, appoggiando il bicchiere — vengo all’Archivio. Non tutta la giornata. Ma vengo. Non per farti piacere. Per… me.
Lui annuì. Non esultò. Accolse.
— Non mostrarmi il mondo intero — aggiunse. — Solo un palmo, come oggi.
— Un palmo — ripeté lui. — Come oggi.
La casa rimise un grado di buio. Fu un segnale gentile: le cose importanti si dicono adesso o domattina. Nessuno dei due ebbe bisogno di traduzione.
Elara si voltò verso il corridoio che portava alla sua stanza. Si fermò sulla soglia, poi tornò indietro di mezzo passo.
— Papà?
— Sì.
— Se un giorno smetto di sognare… ricordami che devo. Anche se non voglio.
— Non smetterai — disse lui con la certezza che a volte gli veniva quando parlava come padre, non come ricercatore. — E se smetterai, ti presterò i miei.
Elara sorrise. Non era un sorriso allegro; era un sorriso intero. Entrò nella sua camera che la casa le aveva preparato come un’opera, e la luce la seguì dentro come un cane fedele.
Il padre restò. Non riaprì il catalogo. Riportò, invece, sul tavolo il piccolo filtro che Elara aveva chiamato “chiave”. Lo posò su una delle sue mappe. La mappa, obbediente, si fece semplice. All’improvviso, dove prima c’erano dieci strati inutili, apparve una linea povera, quasi maleducata, che tagliava un settore come un graffio sull’occhio.
La chiamano coincidenza quando le cose, per un momento, decidono di farsi vedere. Lui no. Lui, a bassa voce, con quella superstizione che sopravvive a tutte le generazioni, la chiamò indizio.
— Randy — disse piano senza distogliere lo sguardo. — Non registrare questo file.
— Eseguito.
La casa si fece più nera di un’ombra. Fu un nero pieno, accogliente, come una tenda che protegge. Il padre lasciò scivolare l’indice lungo il graffio luminoso che la “chiave” aveva reso nudo. Sussurrò una parola che la stanza non trattenne.
Non era un nome. Era un punto nello spazio.
E, con la grazia timida degli inizi, il suo cuore, che aveva imparato a battersi solo per cose antiche, allineò quel punto a un sogno di sua figlia.